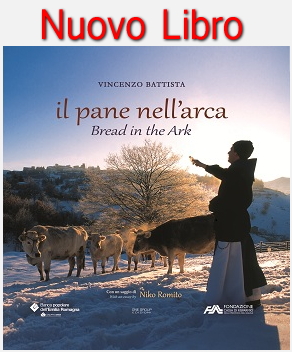Testo di Vincenzo Battista.
Dopo nove ore di volo, L’Africa, un’altra dimensione quando i suoni, odori e colori non si annunciano, inimmaginabili per la loro forza d’impatto, li ho ritrovati addosso, appena il portellone dell’aereo si è aperto; rimarranno così, mixati, anche per tanto tempo, e oltre, persino nei miei sogni torneranno, al rientro, dopo questo viaggio, anche dopo tanti mesi, quasi a volerli trattenere insieme quei ritmi, quelle armonie: effetti acustici di canti, tamburi nella foresta illuminata dai chiarori dei fuochi dei villaggi che attraversiamo e dalle voci nella notte che si rincorrono, mentre sale dentro di noi, primitiva, la scoperta, quasi fosse un’esplorazione, in questa sorta di viaggio-ricerca, di un’altra umanità.
E subito le piste ocra degli altopiani della savana, continue, ma improvvisamente interrotte dai bufali cacciati, dilaniati e divorati dai leoni prima, leonesse e cuccioli dopo, più tardi dalle iene, poi gli sciacalli e infine dagli avvoltoi nella carcassa ormai vuota, ultimo fotogramma di questo ‘spettacolo’, a pochi metri dalla jeep in cui noi, spettatori, siamo ignorati da questa piramide alimentare che aspetta il turno, che ci rivolge ogni tanto uno sguardo, indifferente, tanto quanto basta.
Spazi, confini, sono solo convenzioni, distanze e lunghi tratti da percorrere anche a piedi, in questo lembo dell’Africa subsahariana che è anche altro, tanto altro.
L’otto marzo, nella missione, ma che è soltanto una data, Celeste, Assunta, Angela, Rosaria, Maria Pia, Scolastica, Teresa, Caran e Cladis, si alzeranno alle quattro di mattina, nel luogo dove vivono, nei dintorni di Banguj, nella Repubblica Centrafricana, la nazione più continentale dell’Africa appena sotto l’equatore, “chiusa”, senza “respiro” sull’oceano, la nazione dei pigmei, pelus e nomadi, tribale, con il 45% della popolazione che non raggiunge i 15 anni, dell’imperatore Bokassa (1966 -1979), di tre milioni di africani e un medico ogni quindicimila abitanti, dal 1894 terra di apostolato.
Si alzeranno come ogni giorno nella missione (partita dalla clausura di San Basilio dell’Aquila) intitolata a San Pietro Celestino, il monastero, sorto ai margini della savana e poi oltre la foresta, il bush, per prepararsi ad una nuova giornata di preghiera, ascolto, ma soprattutto aiuto verso le centinaia di persone che lì si dirigono, nel luogo chiamato la “pagliotta”, una capanna in paglia e travi.
Aspettano. Non c’è orario. Vengono per curarsi, per chiedere medicine, vestiario, scarpe. I bambini parlano il sango, mentre gli adulti il francese. Gli anziani cercano il cibo, s’inginocchiano a terra, si sdraiano per quanto si sentono umiliati, dicono le sorelle, cercano farina di manioca, papaia, mais e nocciole. I bambini hanno i vermi nella pancia, la malaria, l’aids, la tubercolosi, il tifo.
“Facciamo quello che possiamo, non rifiutiamo nessuno”, raccontano le suore celestine della missione che preparano le minestre, la “cuncia”: un’erba che si taglia sottile, fine, si cuoce, si lessa con un po’ di carne e le nocciole; oppure il “coco”, una verdura con mais e acqua.
I pigmei arrivano dai villaggi, dalle capanne alzate sulla terra e scavate all’interno di profonde grotte: escono nudi, con i bambini in braccio, e i piccoli portano per mano i fratelli che a malapena si reggono in piedi, dopo molti chilometri, anche quindici dai lontani villaggi, arrivano al monastero. Malati, sono distesi su una stuoia, vegliati davanti alla missione, aspettano le sorelle. A volte i pigmei incendiano la foresta, per far uscire serpenti e topi che mangiano, a causa della carestia, “pensano all’oggi, sono diseredati – ci dice suor Margherita – tanto che una giovane donna incinta, arrivata al monastero, partorì lì, davanti a noi…”.
![17191335_173617866476777_8398424105958933358_n[1]](http://www.vincenzobattista.it/wp-content/uploads/2017/10/17191335_173617866476777_8398424105958933358_n1.jpg)