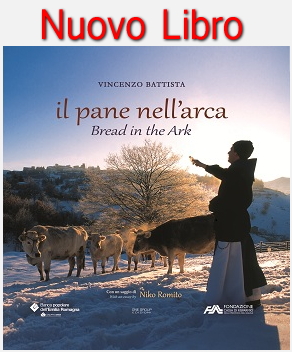Quell’oggetto non identificato nelle campagne di Aragno, frazione dell’Aquila.
Testo e fotografia Vincenzo Battista.
Una forma aliena, sembra. Una macchina d’intelligenza artificiale, non identificata nella notte fonda, ma da lontano luccica e riflette il suo bagliore (complice la luna piena), poggiata su un campo aperto della strada di Aragno prima del borgo (Frazione dell’Aquila). Nessuno sa dirci come sia arrivata lì, nella concezione e nella dilatazione del tempo, poiché la contrazione dello spazio fa sì che in centinaia di anni si resti sempre giovani viaggiando alla velocità della luce nello stesso spazio e nella materia forando il tempo, e questo oggetto non identificato del Terzo Tipo nel buio che lo avvolge, e nella sua solitudine, all’alba, alle prime timide luci, dichiarerà tutta la sua solennità, nel suo effetto di macchina rossa (forse da un satellite si potrebbe persino guardarla) di ferro e legno. Viene da un mondo primitivo e lontano di usi e costumi ( così ne avrebbero parlato gli almanacchi), ma invece è di un’antica società fatta di niente e così era, di maledizione e rabbia, di imprecazioni e dolore, di sudore e schiavitù, di lavoro estenuante “da luce a luce” e lotte contadine e rivendicazioni sociali, di campi di grano e raccolti, di giovani partigiani trucidati dai nazisti, di padroni pochi e contadini tanti senza diritti, di uomini, bestie e montagna nient’altro che montagna ad Aragno, di strade che bisognava ancora inventare ma solo sentieri e poi tutto si chiudeva. E’ lì ferma la macchina aliena, e come un reperto fossile la gente la guarda, si avvicina, la tocca, la scruta, la indaga per capire come sia possibile che da quel “mobile” di quella stazza e possenza possa, dalla sua bocca, prendere i manoppi, di cui lei ingoia e si ciba per poi, nella meraviglia di tutti, restituire il grano, i chicchi di grano (provate a spiegarlo a un bambino). La trebbia di Aragno degli anni ’30 del Novecento. Il monumento dell’immaginario collettivo di un altro” tempo e spazio” appare come un fermo immagine, una cartolina del Novecento, ma è monumento itinerante che trasuda di una narrazione mai scritta del lavoro di questo “obelisco”, che si può trasportare… E quando si anima, dal suo sarcofago i primi vagiti, poi i sussulti, la macchina irriverente – trebbia inizia a scuotersi ( la lunga cinghia di un trattore che la riporta in vita è il suo cordone ombelicale), barcolla e si scuote, accelera, ringhia, gli uccelli volano via, gli uomini sotto il sole la sfamano con i manoppi in continuità, il grano da un boccaporto fuoriesce raccolto infine nei sacchi ( ricamati a mano, alcuni hanno le iniziali degli antenati inizi Novecento), il vino scorre a fiumi. La trebbia serra le fila, ormai vive di vita propria come una prima donna austera, sbraita impertinente e richiama gli uomini a distanza in questo circo mediatico rievocativo, sa di fare bene il suo lavoro tra le urla dei trebbiatori, polvere che si alza della cama ( pula) per diventare una nuvola avvolgente giallastra e cromatica che ti entra da tutte le parti, e i filamenti del grano, la paglia, espulsa, i suoni di legno e ferro della trebbia che si mescolano assordanti, i richiami delle diverse persone che sono intorno per “curare” quell’ordigno spaziale (Sant’Antonio di Padova lo protegge e corre in suo aiuto), addette a trebbiare il grano senza pause. “Così la Signora va bene”, dicono. La trebbia e il suo suono che la letteratura acquisisce, per esempio, in Pascoli nella poesia Patria (1903): “Il palpito lontano d’una trebbiatrice”, oppure d’Annunzio in Alcyone: “Ove l’aie come circhi te trebbie come pugne, come atleti la rustica prole”. La trebbia, che ci riporta a questo paesaggio prima dei motori, al castello diruto delle Ienca sulla destra orografica della valle del Vasto, fondativo della città Nova di Aquila con i suoi confocolieri, dove i luoghi più a nord, come Piano aperto, ricordano l’ara dei carri per la trebbiatura e i proprietari, gli ultimi esponenti della famiglia Genca da cui Demetrio Cappelli acquista l’intera l’area dell’antico castello. Ma poi accade l’inverosimile, 120 famiglie contadine di Aragno, il 4 settembre 1904, grazie anche alle rimesse degli emigrati all’estero, acquistano dal marchese Cappelli la montagna della Genca: riscrivono la storia dei grandi monopoli feudali arrivati fino a loro. Un evento, qualcosa che potremmo leggere solo nei romanzi, ma accade: la rivoluzione e lo sconvolgimento del paesaggio agrario a favore degli ultimi. E cambia tutto, in quella grande area geografica acquistata si coltiva il grano, si apre “un’autostrada”, proviamo a chiamarla così: viaggi continui di uomini e animali che trasportano dalla montagna, da quelle quote della Genca, nelle caie in legno, i manoppi di grano fino ad Aragno. Anche 20 manoppi poggiati sugli animali che pendevano fino a toccare a terra, 4 ore di viaggio andata e ritorno, anche tre viaggi dopo che avevano finito di mietere ognuno nelle proprie particelle acquistate dal marchese. Dall’alba al tramonto inoltrato era un via vai continuo. Le donne portavano i canestri, con la minestra di sagnette con il sugo preparate nelle case contadine nell’uso alimentare di Aragno con lo stesso grano di semola duro e la farina macinata nei mulini, sale, acqua, uova e con ceci, lenticchie e fagioli, dopo che gli uomini avevano falciato il “grano alto di montagna”: una coppa (622 mq) due persone a mietere, riuscivano a tirare circa due quintali di grano. Ricordano ancora oggi: “Le famiglie di Aragno si erano levate dalla fame… “. Quando ridiscendo a piedi la pista di pietre (denominata Inforcatura) e terra arida dal monte Stabiata, alle pendici il paese di Aragno la pista sembra tendersi, come un elastico si allunga e si dispiega, supera le montagne, fino a tracciare e toccare la stessa pista che risaliva il giovane Ignazio Silone ( 1900- 1978 ) a Pescina, dal Fucino: per migliaia e migliaia di volte, al suo fianco ha visto i contadini poveri “ peones, mugin, fellahin, coolie, si somigliavano tutti” così scrive su Fontamara ( romanzo, 1933) : una memoria sensibile senza confini geografici, anche qui su questi passi, che ha fondamento nello spirito della nostra identità, e non invecchia.
Nota.
Un particolare ringraziamento a Renzo Andreoni.
Fabio Gregori e Tomasso Barone sono i proprietari della trebbia di Aragno restaurata con pezzi originali e molte ore di lavoro, e messa in condizione di trebbiare ancora il grano.