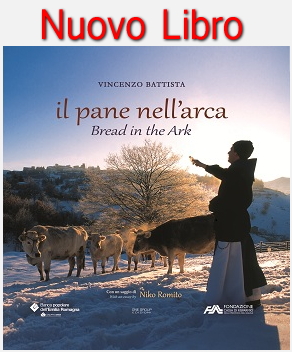Il fiore di zafferano tra Il bene e il male nell’Oratorio di San Pellegrino. Bominaco.
Testo e fotografia Vincenzo Battista.
La pittura monastica di tipo benedettino, realizzata intorno al 1263 ca. e oggetto di successivi interventi nell’Oratorio di San Pellegrino a Bominaco (insediamento monastico di fondazione primitiva, si ipotizza intorno al VIII secolo). L’apoteosi dell’evangelizzazione nella pittura, l’esaltazione e la glorificazione dei Sacri Testi negli affreschi, della Scrittura, che sigilla il Cristianesimo e lo rende immortale, il dettato religioso “scritto” con il pennello sull’intonaco “a fresco”. La magnificenza visiva diventa un tutt’uno con le pareti dell’unica navata e la volta a botte ogivale: la cella delle meraviglie. Si è sopraffatti da tanta sapienza in quell’arca di scienza, in quel tempio della saggezza, in quella seduzione della conoscenza senza più confini da esplorare. La cosmologia dell’Occidente cristiano è tutta qui. E tanto è libera l’interpretazione della pittura che nella parete nord dell’Oratorio, ad altezza d’uomo, l’iconografia attesta e sigilla i demoni trasfigurati in serpenti che inseguono la “femmina” con le mammelle esposte e straziate. I corpi nudi cercano di divincolarsi (la salvezza della loro anima) in una via di fuga improbabile. La donna, strumento di perdizione nulla può fare, e Satana di colore verde ( in quella stesura cromatica così era rappresentano in epoca medievale) con la sua corte di diavoli e demoni travestiti nel serpente immondo inseguono, straziano e inghiottono i dannati: la natura insaziabile di Satana attenta alle virtù, la donna è la più esposta, la peccatrice, si vuole persino possederla in una scena dell’affresco, qualcuna arde tra le fiamme, in questa letteratura pittorica apocalittica in sequenze narrative e incalzanti, affiancate, che non danno respiro e atterriscono, in questo male profondo, monito e messaggio subliminale in un tempio religioso dove il bene e il male si fronteggiano in una furia iconoclasta, e per la efferatezza visuale, impattante. Questa serie di affreschi si rivolge a loro, pellegrini, coloni, contadini popolo minore. Metterli in guardia, pronti a soccombere alla tentazione, perdere il paradiso, cadere nella morte eterna nella visione pessimistica dell’uomo, debole, vizioso e umiliato davanti a Dio, è presente per tutta la durata del Medioevo. Utilizzare, quindi, il più efficace modello visuale di pittura per dire a che cosa andrebbero incontro, in quello schermo mediatico dell’Oratorio di San Pellegrino, se voltassero le spalle alla Chiesa, non si convertissero ai sacramenti e all’insegnamento del Vangelo, la fede nella redenzione, se non osservassero la penitenza e l’ossequio intorno alle strutture conventuali aggregative sempre più bisognose di manodopera per le loro rendite diffuse nel contado. Quell’uomo medievale pieno di paure e superstizioni, angosciato dal suo tempo, dopo questo “male” profondo appena osservato, nella stessa parete, dell’Oratorio di San Pellegrino, quindi, ritrova il “bene” nel calendario monastico dei mesi dell’anno e nel lavoro dei campi nel contado dentro le monofore trilobate dipinte e d’ispirazione dei miniaturisti bizantini del XI secolo. Il messaggio spirituale, la civiltà della ragione sul male. Una sorta d’ingrandimento dagli antichi codici amanuensi. I primi sei mesi dell’anno sono pressoché integri, il secondo semestre è compromesso per il deterioramento in cui si presenta, restano solo alcune tracce pittoriche. I mesi dell’anno, il lavoro nei campi e i contadini (saranno così abbigliati?) nell’allegoria che li rappresenta, personaggi a dir poco “eleganti” nelle loro pose curtensi (addirittura nel mese di gennaio uno di loro sorride davanti al fuoco, sembra indossare un saio), su tutte quelle figurazioni svettano i segni zodiacali che guidano la lettura dei mesi: enigmatica presenza, superstizione, non certo assimilabile al dettato cristiano che rigetta l’oroscopo. Nel mese di ottobre, nel calendario, è dipinto un grappolo d’uva simbolo della vendemmia ma è mancante il “logo” dello zafferano, il segno di riconoscimento identitario di una pratica agricola largamente presente in queste terre, ma ci penserà Buccio di Ranallo a ricordarlo. Il cantore epico medioevale nella sua “Cronica aquilana” nel 1360, in una sintesi configura il paesaggio agrario: “…de vennegnare le vigne, pistare et recare, sfiorare la soffrana, arare et seminare”. Lo zafferano. E se i serpenti attentano ai capezzoli della donna, come visto negli affreschi di San Pellegrino, questi venivano, viceversa, colorati con pasta di zafferano per aumentarne il potere di seduzione, e poi nei cuscini delle domus romane, profumi, nei bagni degli imperatori, schiume per tingere i capelli delle matrone, sparsi i fiori di zafferano davanti i templi e le colonne dipinte con lo stesso fiore, fino alle qualità alimentari citate da Dioscoride, nel I secolo. Il cibo, allora, da considerare un elemento culturale, tanto più in relazione allo zafferano e alle componenti geografiche del territorio che permettono di mantenere viva la sua cultura, l’identità delle proprie radici, in una società dell’alimentazione fragile, discontinua e migratoria. Lo zafferano, indubbiamente identitario, etnico, espressione del paesaggio come Bene culturale (nella trasmissione delle competenze, nonché della conoscenza di rituali, gesti e celebrazioni tradizionali, e nella salvaguardia delle tecniche) che arriva alla tavola, e comprende sì le coltivazioni, per esempio nell’area dell’altopiano di Navelli, ma anche un nuovo un modello nutrizionale che si affaccia e cerca una sua legittima collocazione, nel “cibo del rito e del gusto” più che un’idea un segno distintivo di un brand questo, appena esposto, a cui bisognerà riflettere e riprogettare, come mai nel passato di questo territorio ancora non in grado di avere una “visione” e proiettarsi nel suo “autunno” certo, adesso, per usare un eufemismo e che vede sbocciare, nello spazio e nel tempo, ancora il timido fiore di zafferano…
Lo zafferano e i beni alimentari.
Tortelli all’agnello con burro, zafferano, limone e rosmarino. Agnello alla fric- frac (veloce) con rosmarino, aglio, alloro servito con una ferratella salata con santoreggia e zafferano. Agnello cacio e uova con zafferano e pane di solina (grano antico) croccante. Ravioli di ricotta di pecora con zafferano e salvia. Pastiera aquilana con farina di rosciola (grano antico), ricotta di pecora, miele di lupinella, zafferano e lenticchie di Santo Stefano di Sessanio. Semifreddo (albume e panna vegetale) con liquirizia di Atri, zafferano e meringa.
Letizia Cucchiella Lady Chef (il compartimento delle Lady Chef ha l’obbiettivo di valorizzare la donna nella professione dell’associazione fic – federazioni italiana cuochi), sua nonna Margherita preparava il cibo per gli operai che sbancavano le rocce per aprire la strada a Santo Stefano di Sessanio. La madre, Rosa Ciarrocca, cuoca della ristorazione nel borgo di Santo Stefano di Sessanio.