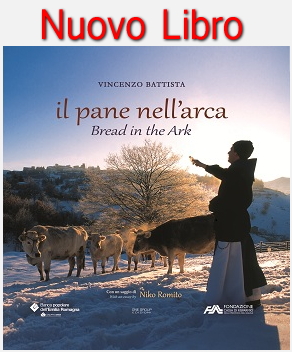Lo scirocco del vino sulla valle dell’Aterno.
Testo e fotografia Vincenzo Battista.
“Il cielo s’infoschiva, si caricava di nuvole e fiatava uno scirocco molle (la prima settimana di novembre). Poi cominciava a piovere; e la notte i contadini si destavano dal rumore delle muraglie che franavano dai campi, trascinando la terra che, in quel paese di montagna arrampicato anch’esso sulla roccia, come i suoi magri vigneti, vi era stata portata con le ceste, a spalla. Si destavano allarmati, e cercavano d’indovinare dal rumore la direzione e la distanza di quelle frane improvvise e catastrofiche. Nel mattino livido accorrevano a vedere i danni.” scrive Giovanni Titta Rosa (1891 -1972) ne “L’Avellano”, un libro, ma forse un lungo epistolario (Tione, Santa Maria del Ponte e i borghi della media valle dell’Aterno) di un mondo di elementi naturali, ostili, narrato con atmosfere tali da esaltare la lotta dell’uomo “siloniano”, la consapevolezza di essere schiacciato nel proprio tempo, intesa come cultura di una rassegnazione, ciclica, dell’uso del territorio arcaico, aspro, che ha in sé i caratteri sostanziali e irripetibili – nel tempo e nello spazio – di un avamposto montano abruzzese. Comunque da difendere.
“La grande conversazione” di Titta Rosa tra la natura e l’uomo, così scrisse Benedetto Croce, cioè il contributo alla conoscenza della regione remota e difficile da vivere nella sua realtà naturalistica e antropologica con le sue tradizioni e i suoi miti, che proprio in questi giorni diventano protagonisti di una misconosciuta microstoria sociale ed economica: la viticoltura.
Le botti dei De Marchis, Muzi e Corvi erano talmente grandi che potevi entrarci dentro – racconta la tradizione orale locale – per pulirle. Erano i padroni, i proprietari terrieri, avevano le vigne. L’uva si poteva vendere dovunque, c’era allora, in abbondanza; una grande quantità di vigneti lungo le coste della montagna, nei pianori, nei terrazzamenti ma meno che nel fondovalle del fiume. I compratori venivano dal nord Italia, allo scalo ferroviario della stazione di Fontecchio dove tutta la popolazione – raccontano – portava l’uva con le ceste caricate sugli asini e la depositava nei vagoni. Per fare un ettolitro di mosto occorrevano 130 chili di uva, ed infine si producevano circa 80 litri di vino “pulito”.
Durante la vendemmia si riuniva la famiglia, il vicinato e qualche operaio. Si pigiava allora con i piedi nudi. Ma non tutti i contadini avevano la vasca di raccolta del mosto, il pilone e il torchio. Il proprietario del torchio, ad esempio si prendeva una parte delle vinacce, la “ripassatura”, la sua quota. Ai contadini, infine, dopo la vendita dell’uva o del mosto, pagato il padrone, non restava che “l’acquata”, “l’ultima ripassatura” delle vinacce nel torchio, quando questo non ce la faceva più “a stringere”. Si metteva poi nel calderone in rame, si cuoceva, ” ma non era niente – continua il racconto – durava poco nell’arco dell’anno.”, dentro il caldaio alimentato dal fuoco scendeva di un palmo, ed era pronta “l’acquata”, anche questa da iscrivere nella storia del paesaggio agrario, nella memoria, come documento, della valle, difficile e remota, lontana, ancora oggi. La processione: “una scienza esatta”, una sorta di disciplina preparatoria, propedeutica, in grado di tutelare e salvaguardare con il suo rito propiziatorio i campi, ingraziarsi la santità, accattivarsi la protezione degli elementi naturali, sempre in conflitto tra loro. Per questa ragione le solenni processioni verso le vigne erano diventate soprattutto un’ossessione, un rito ciclico, ma prima, ma molto prima che si arrivasse alla vendemmia: un test questo, atteso, nell’economia agricola di vendita e scambio praticato un tempo, da queste parti, un test che misurava l’anno agricolo, i profitti, il bilancio delle famiglie contadine; un test che ridisegnava il calendario: se la vendemmia andava bene si poteva andare nelle fiere e nei mercati autunnali, e comprare.
Da Rocca Preturo (frazione di Acciano) la processione muoveva il giorno di San Marco dalla chiesa verso le vigne, per la siccità di queste, da scongiurare; il prete benediva, la gente pregava, le campagne venivano acquietate; contro la grandine “alla Candelora”, le candelette si portavano nei vigneti, sempre in processione. A Goriano Sicoli prendevano il pane contro il temporale, perché lì, nel mese di maggio, si celebra Santa Gemma; a Castel di Ieri, nella festa di San Luigi somministravano il pane, contro la tempesta per proteggere e “cibare” i terreni: cerimonia e sacrificio s’incontravano, la religione cedeva il suo primato, per un momento scendeva a patti con quell’archetipo primordiale bisogno di tutela oltre la cristianità, di quei miti antichi offuscati e irriconoscibili allora, sprofondati nell’antropologia del tempo degli antenati a cui la gente si appellava: simboli improbabili per scongiurare le avversità e “guarire” il cattivo raccolto delle vigne. Qualcuno parlava appunto di quei simboli come un lascito antico, un testamento orale, risalito dalle “profondità” del paesaggio, dalla parola ereditata, mescolato insieme alla santità locale che veniva in aiuto dei vigneti: dalle case si buttavano fuori i soffietti dei camini, gli spiedi in ferro, si allontanavano dalle abitazioni per bloccate i tuoni, le saette e quei temporali che dilavavano i declivi, le frane sbancavano le vigne, e dopo averle distrutte, scendevano a valle nel fiume Aterno insieme alla responsabile, riconosciuta religione della santità, capro espiatorio, per un momento abbandonata dai cristiani.