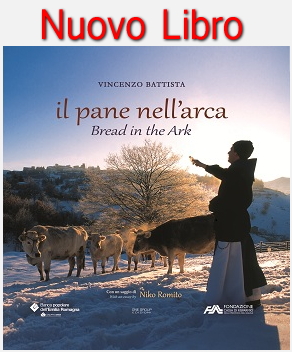Testo e fotografia di Vincenzo Battista
Quando “usciva padre Girolamo” nel quartiere Santa Croce, L’Aquila, la città, sembrava sconosciuta, lontana, uno “schermo” con le immagini che arrivavano raccontate dai genitori; passavano, senza apparente significato. Mai desiderata L’Aquila, forse percepita, non lo sapremo mai; distante sì, in quell’immaginario dilagante e incatturabile dei ragazzi con i pantaloni corti, anche d’inverno con la neve. Quando “usciva padre Girolamo” la città, questa sì, chiamata Santa Croce, “completa”, spaziale quanto bastava e in un solo colpo d’occhio delimitata; chiusa e protetta, certa nella sua frontiera, il suo perimetro, percorso e vigilato, il castrum, una fortificazione con al centro invece di un decumano, una ripida discesa con la chicane per il gran premio di Formula 1 che apriva la stagione: “carrozze” in legno e cuscinetti in ferro delle case costruttrici, i marchi, prototipi tenuti segreti, realizzate nei sottoscala dei palazzi di Santa Croce, con un manubrio, un asse sempre di legno per curvare. I pedoni le vedevano, urlavano, schivate solo all’ultimo momento, per non essere travolti, in quel rumore di ferro e asfalto e adrenalina pura ma che allora si chiamava in un altro modo. E poi mura antiche e camminamenti, archi, palazzi come torri per nascondersi, piazze d’armi improvvisate e persino un agorà greca per il fuoco di San Giovanni del 24 giugno, la prova iniziatica: saltare il falò, alla ricerca ancestrale del primato, il superamento della quotidianità, mostrato, ostentato. Il palazzo dei “questurini” come una sorta di presidio dell’Unesco, e per non farsi mancare nulla anche un monastero diruto del ‘300, una sorta di Cinecittà, gli Studios. Si girava l’assedio di “Montecassino” della seconda guerra mondiale, da conquistare con le cerbottane, e i proiettili, i cartoccetti sparati per stanare i nemici, accompagnati dai droni, cioè le “azze” dei biancospini legate con un filo intorno alla testa, e fatte volare anche all’altezza anche di un secondo piano. Ma poi si continuava con i teschi dell’ossario e l’unica cosa che saltava in mente era quella di giocarci a calcio. In una scenica ” Full Metal Jacket”, si combatteva, anche corpo a corpo, e con le spade in legno e gli scudi di cartone del nostro immaginario, molti secoli prima, andava in onda la guerra di Troia. La sceneggiatura prevedeva i cumuli di macerie secolari del convento di Santa Croce e i guerrieri con armature di cartone. “Achille restituiva il corpo di Ettore” che così poteva essere sepolto e trovare pace, si diceva. Achille poi piangeva, non perché rivedeva in Priamo suo padre davanti al cadavere di Ettore come vuole la narrazione dell’Iliade, ma perché a calci e schiaffi veniva riportato a casa, dopo che tutto il quartiere si era mobilitato, la madre piangeva, il padre bestemmiava, lo avevamo cercato, trovato poi, ma a tarda sera. Non si capirà mai perché si era nascosto nell’ossario della chiesa di Santa Croce a ricomporre uno scheletro con grande perizia, nemmeno dopo un lungo interrogatorio…Veniva messo in prigione, dietro i vetri della casa ci guardava, accennava un saluto, doveva espiare la pena, ma era diventato un eroe, Achille. L’essenza di tutto questo, i ragazzi di Santa Croce, che non riuscivano ad essere normali: scout, lupetti nel giuramento solenne e salesiani dell’oratorio Don Bosco la domenica a servire la messa per vedere le pulzelle, “straniere”, degli altri quartieri, guardati con sospetto da sor Erminio, e infine ” I ragazzi della via Pàl” (il romanzo che nessuno aveva letto) nel resto della settimana nella loro “citta”: un cambiamento genetico, inspiegabile, arcano. Quando “usciva padre Girolamo”, la sua missione non era quella di girare in pellegrinaggio nella provincia dello Shaanxi in Cina, ma dalla sua “casa”( un recinto con le pietre a terra che delimitava uno spazio), come un fenicottero con un solo piede poggiato a terra, usciva Girolamo ( un ragazzo estratto con la conta) e si fermava per studiare la “situazione”. Con quel solo piede che saltellava, cercava di raggiungere in “missione” gli altri ragazzi, un branco di lupi magri e famelici che si erano riuniti pronti a “colpire”. Bisognava toccarli, uno alla volta con le mani, e se così avveniva, sarebbero diventati suoi figli redenti dal ”peccato originale”. Questi, dopo, dovevano correre, nella “casa”, il luogo certo, invulnerabile, velocemente, prima che una violenta scarica di calci, pugni, sberle li ricoprisse nel breve tragitto, in una “teologia del corpo umano” che voleva così la sua prova ordalica, “magica – religiosa”, per tutti. Un gioco crudo, duro, come per i Juvenilia romani, “Il superamento, un’iniziazione per placare la sete, lotta eterna tra il bene ed il male, scacciato. Si diventava adulti, forse. Tallonatore, pilone, mediano di mischia, seconda linea, tre quarti d’ala, ma con “salta la mula”. Una sorta di mischia “salta la mula”, forse propedeutica al rugby (molti quando lasceranno “la città” andranno a giocare a rugby), e lì, scendevano in campo i pesi massimi del quartiere amati tanto da essere tenuti a distanza, non si sa mai. “Il rugby è una buona occasione per tenere lontani trenta energumeni dal centro della città”, scriveva Oscar Wilde. Si iniziava con una lunga fila , con la faccia che guardava a terra e la schiena piegata parallela al terreno. Ciascuno teneva con le braccia i fianchi del compagno che aveva davanti. Si formava così una lunga fila di schiene, terminata, infine, nell’ultimo compagno, in piedi con la schiena appoggiata alle mura medioevali. L’altra squadra, ma uno alla volta, doveva saltare a cavallina sopra la mula. Si saltava con lunghe rincorse, nella piramide umana che prendeva le forme più bizzarre, come un souffle che si gonfia a dismisura e poi inizia a cedere da qualche parte. Anche per lungo tempo tra urla e imprecazioni si rimaneva ancorati per fiaccare la mula: come “ju ruspu alle sassate”. Quelli giù dovevano tenere; aggrappata sopra, l’altra squadra, provava a resistere . Chi passava con le buste della spesa, non poteva far altro che guardare quello spettacolo,” quei deficienti” – dicevano – che chiusa la scuola, si riunivano o battevano in lungo e largo la frontiera e il quartiere: se ne impossessavano con le loro regole. “Ulisse di Itaca” , giovane ma di un civico al terzo piano di un palazzo del quartiere , riuniva i suoi compagni a “buzzico”, “in notturna”. Con la sua astuzia e la mancanza di scrupoli, si lasciava per ultimo, niente doveva essere d’impedimento all’impresa: resistere, depistare e liberare tutti usando le tecniche più raffinate, i nascondigli, i travestimenti dentro la magia della notte. Sotto un lampione si calciava con i piedi un barattolo, poi tutti scappavano e si nascondevano, solo uno lo raccoglieva, ne restava a guardia, ma doveva scovare gli altri, individuarli, chiamarli per nome e battere poi tre volte a terra “ju buzzico”. Per liberare i prigionieri l’ultimo, l’Ulisse salvifico, doveva arrivare vicino alla ” tana”, non farsi vedere, calciare il barattolo e liberare tutti. Si Rimaneva sempre all’erta, attenti a quel rumore , al suono che rimbalzava per scappare, al suo primitivo messaggio fatto di niente, di quanto poco potesse bastare intorno a quel barattolo, penso, mentre lo raccolgo, poggiato su un muretto, forse servito per una pietanza, per qualcuno che ha lavorato per sgombrare le macerie ed è andato via, mentre scendo a piedi il ripido rettilineo, prima della chicane, nel silenzio che mi circonda, in una angoscia criptata, a stento trattenuta, ma puntuale arriva, davanti a quello “spettacolo” dei palazzi esplosi. Ogni tanto ci torno a Santa Croce. E’ come scavalcare la cornice ed entrare in quadro metafisico di Giorgio De Chirico: l’enigma, l’assenza dei personaggi umani e la solitudine; scene ferme davanti ai nostri occhi, ma fuori del tempo.
Tornare lì è sempre un viaggio nuovo, una sorta di pellegrinaggio all’antica come scriveva Ignazio Silone, mai uguale a se stesso, fino a casa di mia madre, squarciata, sempre più aperta, sempre più vivisezionata, una “Lezione di anatomia del dottor Tulp” di Rembrandt, sempre più “indagata” dall’esterno: metamorfosi delle rovine nel divenire in continuo disfacimento nei crolli, come se non bastasse, non avesse fine. Forse è la metafora della vita degli aquilani, inconfessabile, quello che resta osservato dai bordi della città anche dopo tanti anni, in quell’impotenza opprimente, cha fa abbassare gli occhi. Una volta commisi l’errore di portarla a Santa Croce, mia madre ottantenne, a rivedere la casa. Lei si aggirava intorno, la guardavo, muoveva le braccia, mappava forse “quella notte “, quando tutto ebbe inizio, gli intonaci si torcevano in un rumore irriproducibile, si scuotevano prima, si aprivano poi, e come in un video games mia madre usciva, curva e incosciente, trovava una lesione nella parete del primo piano da cui entrava un po’ di luce, mentre dietro a lei cadevano le mura, si univano in cumuli i detriti, ma dopo che era passata. Dopo.
Più tardi dirà del pantheon di divinità, includendo i familiari, che l’hanno protetta; la soprannaturalità religiosa che decide i destini, intervenuta, impalpabile, o il caso e la necessità che lottano tra loro, “decifrano” , una sorta di cammino sul filo del rasoio tra resistenza e declino, tra vita e morte, che ha scelto la prima, comune, a tanti, che si sono salvati. Prima di andare via, come se ci fossimo dati appuntamento, tra le mani una cassetta di pomodori bolliti, in bottiglia, datati, che avevo preso dalla cantina, davanti a me, e in quel modo, la pattuglia del 113 . Resto così, fermo, guardo la scena: mia madre lentamente si avvicina, si appoggia alla macchina e piange, la donna poliziotto abbassa il vetro del finestrino e piange, l’autista si commuove. Resto così, dentro Santa Croce e le sue voci . . . Se poggi l’orecchio a terra, puoi sentirle.
Le fotografie aeree mostrano il quartiere Santa Croce e le zone adiacenti.